Vittorio Pelligra è professore di Politica Economica all'Università di Cagliari. I suoi interessi di ricerca riguardano la behavioral ed experimental economics, l'economia civile e le neuroscienze sociali e cognitive. E' ricercatore associato del CRENoS (Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud) e fa parte del comitato scientifico della SEC – Scuola di Economia civile. E' co-fondatore di SmartLab e di Wecoop, due imprese che operano nel settore della data science e dell'edutainment. Sul Il Sole 24 Ore cura la rubrica domenicale Mind The Economy.
- 01 febbraio 2026
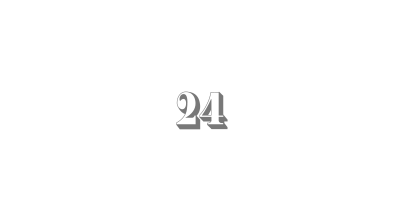
Perché il lavoro è diventato uno spazio senza democrazia
Spendiamo gran parte della nostra vita adulta in luoghi in cui qualcun altro prende decisioni per noi. Non possiamo votare, non possiamo dire la nostra, non possiamo partecipare attivamente. Luoghi in cui scelte che incidono direttamente sul nostro reddito, sul tempo di vita, sulla possibilità di
- 25 gennaio 2026

Elizabeth Anderson e la giustizia come relazione sociale
Siamo portati a pensare alla giustizia sociale come ad una faccenda principalmente distributiva. Chi ha quanto, chi guadagna di più e chi di meno e come trasferire ricchezza, servizi, opportunità, in modo da rendere la distribuzione più egualitaria. Ma questa prospettiva quantitativa rischia di
- 18 gennaio 2026

Quel lavoro prezioso che la politica non riconosce
Se prendiamo sul serio l’idea che la vulnerabilità e la dipendenza non siano eccezioni ma condizioni ordinarie dell’esperienza umana – come da anni sostiene l’etica della cura – allora ne deriva, inevitabilmente, che la cura non può più essere pensata come un fatto privato, né come un’appendice
- 11 gennaio 2026

La cura come base imprescindibile della giustizia
La teoria della giustizia moderna nasce sotto il segno dell’autonomia. L’individuo giusto è colui che sceglie liberamente, che stipula contratti, che rivendica diritti in condizioni di eguaglianza formale. Si tratta di soggetti razionali, liberi, “membri pienamente cooperativi della società per la
- 04 gennaio 2026

Chi si prende cura di chi si prende cura?
Periodo natalizio. Per molti è tempo di vacanze. Ci piacerebbe passare qualche giorno in montagna, partiamo. Per altri la vacanza non è mai stata davvero un’opzione. Una famiglia con un figlio con disabilità prova a organizzare qualche giorno fuori. La prima ricerca riguarda l’accessibilità
- 29 dicembre 2025

Quando il contratto sociale funziona, ma non per tutti
L’ascensore della stazione è fuori servizio. “Ci scusiamo per il disagio” c’è scritto su un cartello plastificato. Due persone si fermano, leggono, sospirano e proseguono in direzione delle scale. Qualche gradino, un po’ di fatica, cinque minuti persi. Poi la giornata riparte. Ma non è così per
- 21 dicembre 2025

Gauthier e la giustizia senza virtù
Fino a che punto la ragione può imporre vincoli alla propria libertà, senza fare appello a ideali morali esterni? È sempre stata, questa, una delle domande centrali della filosofia moderna. Da Hobbes a Hume, da Kant a Rawls, molti pensatori hanno cercato di determinare se l’idea di giustizia
- 14 dicembre 2025

La politica come architettura delle possibilità
“Non è accettabile un mondo con pochi predestinati seduti a banchetto e molti altri destinati a sperare di ricavarne alcune briciole”. Fa molto bene il Presidente Mattarella a ribadirlo, è uno dei pochi, del resto. Il tema della giustizia sociale – fateci caso - è del tutto sparito dall’agenda
- 07 dicembre 2025

Quando la disuguaglianza uccide le democrazie
Nel suo ultimo, importante libro Why Social Justice Matters (Polity Presss, 2005) Brian Barry anticipa di vent’anni il dibattito attuale intorno alla crisi delle democrazie occidentali. I dati di questa crisi sono sotto gli occhi di tutti. È di qualche giorno fa il dato emerso nel Rapporto Censis
- 30 novembre 2025

Brian Barry e l’imparzialità come fondamento della giustizia sociale
Quando i sentimenti o la devozione non sono sufficiente a risolvere i conflitti l’unica via che resta è “l’uso della ragione, dell’imparzialità, del compromesso ragionevole”. Si apre così, con questa citazione di Karl Popper, Justice as Impartiality (Clarendon Press, 1995), il secondo volume del
- 23 novembre 2025

Brian Barry e la giustizia oltre il ricatto
Che cosa rende giuste le istituzioni? Negli ultimi cinquant’anni, da John Rawls a Amartya Sen, da Michael Walzer a Nancy Fraser, la ricerca di una risposta a questa domanda ha dato vita a modelli, concetti, esperimenti mentali che hanno ridisegnato il modo in cui oggi pensiamo la convivenza
- 16 novembre 2025

Nancy Fraser e le quattro ferite del “capitalismo cannibale”
C’è una frase, nelle prime pagine di Capitalismo cannibale, l’ultimo libro della filosofa Nancy Fraser, che possiede la forza di una sentenza: il capitalismo è come un uroboro, il serpente mitologico che si divora la coda. È “un sistema — scrive la Fraser — programmato per divorare le basi sociali,
- 09 novembre 2025

Nancy Fraser e la giustizia “tridimensionale”
C’è una questione fondamentale, nel dibattito contemporaneo sulla giustizia, in cui l’economia incontra, o si scontra, con l’etica. Una questione che interroga la politica sollecitandola a dismettere i panni della mera amministrazione dell’esistente per tornare a rappresentare l’interrogazione sul
- 06 novembre 2025

Giustizia e dignità del lavoro, i concetti non perduti sui quali insiste Sandel
Ho incontrato Michael Sandel, pochi giorni dopo l’annuncio dell’assegnazione del Berggruen Prize for Philosophy and Culture 2025. Conversando con lui ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un chiaro esempio di intellettuale civico. Un intellettuale nel senso proprio che a questa figura
- 02 novembre 2025

La giustizia oltre i confini della specie
L’immagine che apre The Expanding Circle (1981) di Peter Singer è potente ed evocativa. La moralità, scrive, è come un cerchio che si allarga progressivamente: “Un tempo i legami affettivi abbracciavano soltanto la famiglia; poi il cerchio, espandendosi, ha iniziato ad includere prima una classe,
- 26 ottobre 2025

L’altruismo efficace e l’idea di giustizia
L’etica pratica di Peter Singer riporta la filosofia morale nel suo terreno d’origine, quello in cui le idee si misurano con le sfide e i dilemmi della vita concreta. La sua filosofia, in questa prospettiva, interroga l’economia - la scienza triste dell’uso efficiente delle risorse - per formulare
- 20 ottobre 2025

Giustizia è il dovere della compassione
Quando Peter Singer approda a Oxford nel 1969, è un giovane studente australiano con l’aria distratta e le tasche vuote. Non immagina che da quella città grigia e austera prenderà forma una delle rivoluzioni morali più influenti del secolo. Figlio di ebrei viennesi scampati al nazismo ma cresciuto
- 12 ottobre 2025

La misura e il volto. L’eredità inquieta di John Harsanyi
Nato nel cuore martoriato della Mitteleuropa, in una Budapest che portava addosso la nostalgia dell’Impero e le crepe del secolo breve, John C. Harsanyi, cresce figlio di una terra dove l’intelligenza convive con l’angoscia, dove l’ironia serve a sopravvivere al potere, Tra la musica di Bartók e il
- 05 ottobre 2025

John Harsanyi e il sogno di una giustizia matematica
John C. Harsanyi è nato tra le macerie della storia nella Budapest del 1920 e cresciuto nel clima inquieto dell’Europa dei totalitarismi. Brillantissimo negli studi nel 1944 si laurea in farmacologia. Durante l’occupazione nazista, in quanto ebreo, viene rinchiuso in un campo di concentramento e
- 28 settembre 2025

Da Aristotele ai mercati algoritmici, quand’è che un prezzo è il giusto prezzo?
C’è un filo che attraversa la storia economica e morale dell’Occidente come un fiume carsico che scorre sotterraneo e di quando in quando riemerge in superfice: è l’idea che il prezzo di un bene non sia soltanto un “prezzo”, ma rappresenti un giudizio di natura morale, politica, culturale su ciò
