- 16 dicembre 2024
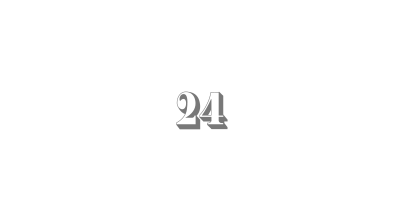
Femminicidio e Patriarcato nell’ambito della violenza di genere
Una revisione ragionata dal punto di vista del delitto e della criminologia
- 23 ottobre 2020

L’isola che non c’è. Forse c’è. Dipende
Nel suo «Helgoland», Carlo Rovelli ci guida alla scoperta di un mondo pieno di fascino dove la realtà è fatta di relazioni prima che di oggetti
- 30 luglio 2020

La gravità, una vera attrazione
La storia affascinante della presenza che agisce sotto di noi e ci tiene con i piedi per terra
- 25 giugno 2019

Matematica e fisica: matrimonio sbagliato
Matematica e fisica, storia e filosofia: gli anacronistici abbinamenti della scuola gentiliana in vigore dal 1923
- 17 agosto 2017

Il futuro è per atenei più eclettici
Mi sono laureato in chimica nel 1976 e anche allora le prospettive accademiche erano limitate. Dopo alcuni anni all'estero, ho avuto una carriera ricca di soddisfazioni alla Federico II di Napoli e alla Normaledi Pisa.
- 29 luglio 2017

Errori veri e presunti di Einstein
Per garantire un introito al suo collaboratore Leopold Infeld, che non aveva ancora un posto in università, nel 1938 Einstein decise di scrivere assieme a lui un saggio destinato a diventare famoso, L’evoluzione della fisica. Durante la stesura Infeld gli confessò di sentirsi particolarmente in
- 24 luglio 2017

La particella dal doppio «charm»
«Three quarks for Muster Mark!». Nel 1964 il fisico statunitense Murray Gell-Mann si ispirò a questa misteriosa frase tratta da Finnegans Wake di James Joyce per battezzare i mattoni fondamentali della materia, i quark. La parola cruciale nella frase è la prima, three: tre erano infatti i quark
- 22 giugno 2017

E se le ruote delle biciclette fossero quadrate?
La curiosità, il motore principale della scienza, prende forma in due tipiche domande. La prima, la più seria, è ovviamente: «Perché?». È la classica interrogazione sulle cause, sui meccanismi, sulle leggi di natura, che attraversa tutta l'impresa scientifica. Ma c'è una seconda domanda, più ludica
- 12 giugno 2017

Le particelle nate in cantina
La scienza non procede linearmente, per accumulo, ma errando (in tutti i sensi), e una confutazione – come insegnava Karl Popper – vale più di una conferma. Guardiamo per esempio che cosa accadde settant’anni fa, in quel 1947 che a buon diritto può considerarsi l’anno di nascita della moderna
- 22 marzo 2017

Tempo da cristallizzare
Che cos’è un orologio? Essenzialmente è un sistema periodico – un sistema le cui configurazioni si ripetono identicamente dopo un certo periodo, che può essere assunto come riferimento per misurare il tempo. Si tratti di un pendolo, di un pianeta che gira attorno al Sole o di un atomo che oscilla
- 06 novembre 2016

Una «leva» per capire il mondo
La matematica, diceva il grande teorico dei numeri André Weil, non è nient’altro che un’arte, «una specie di scultura in un materiale duro e resistente, come certi porfidi». Ma per quale motivo quest’arte che si esercita su una materia mentale abbia così tanto successo nel descrivere la materia
- 23 settembre 2016

Se la natura è senza Dio
C’è stato un tempo in cui ragionare sull’universo poteva costare la vita. Il caso di Giordano Bruno, arso vivo nel 1600 a Campo de’ Fiori, è il più famoso ma non l’unico. «Andiamo allegramente a morire da filosofi», pare che abbia detto il 9 febbraio 1619 un altro grande visionario, il salentino
- 02 settembre 2016

Verso gli orologi nucleari
Se uno degli orologi più sofisticati di cui attualmente disponiamo avesse cominciato a segnare il tempo al momento del Big Bang, oggi sbaglierebbe di meno di un secondo. È la strabiliante accuratezza degli ultimi orologi atomici, che accumulano un secondo di errore ogni quindici miliardi di anni,
